E tu che padre sei?
GEO gennaio 2006
Scarica il mio articolo sulla paternità.pdf
Cinque figli, tutti in orfanatrofio per poter lavorare in pace. Un disgraziato? Dipende dai punti di vista. Si tratta del filosofo francese Emile Rousseau, autore, tra l’altro, di un famoso trattato di pedagogia (Emilio o dell’educazione, 1762). Come scrittore fu geniale, come padre un disastro. Ma chi è un buon padre? Se lo sono chiesti quest’anno cinquecento esperti, a Oxford, per il primo summit planetario sull’argomento, patrocinato dall’Unicef e organizzato da Fathers Direct, il centro studi inglese sulla paternità. Risposta: i padri migliori sono i pigmei Aka del Congo, poiché stanno in contatto fisico con i figli per il 47 per cento del loro tempo. Seguono gli svedesi, che dedicano quasi la metà del loro tempo ai figli. Gli Aka vincono con un colpo alto: in assenza della madre offrono il capezzolo ai piccoli, per calmarli.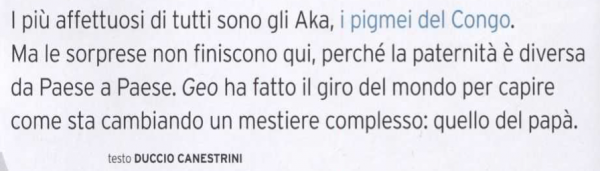
Ma delle 156 culture prese in considerazione dal report di Fathers Direct (pubblicato sulla rivista FatherWorld) soltanto il 20 per cento promuove una stretta relazione tra padri e figli. Anche se un dato universale è la progressiva crescita dell’impegno paterno sul fronte domestico. In Inghilterra, negli ultimi trent’anni, la presenza fisica dei padri in famiglia è aumentata di ben otto volte. Molte le motivazioni, non sempre pedagogiche. Tra i malavitosi di Los Angeles, per esempio, diventare padre e dedicarsi ai figli è la sola “scusa” per lasciare la gang... e sopravvivere.
Domanda: non sarà un tantino “ideologica” la graduatoria ispirata dall’Unicef? In altri termini: siamo sicuri che il buon padre debba essere materno? E ancora, siamo sicuri che il buon padre debba essere presente? Lo nega, un po’ provocatoriamente, il grande psicologo James Hillman: “Papà, dove sei? Sei tornato?”. No, piccolo, papà è a pranzo con i colleghi. Dove è giusto che sia. Il suo posto è altrove, perché il suo valore fondamentale per la famiglia consiste nel mantenere i contatti con l’altrove”. Posto che per secoli i padri sono stati assenti, e che soltanto oggi quest’assenza è così ignominiosa da essere definita una condotta delinquenziale, secondo Hillman “Papà deve tenere un piede in un altro spazio e un orecchio sintonizzato su altri messaggi.” (Il codice dell’anima). Il report Fathers Direct costringe comunque a chiedersi in che cosa consista la paternità. A quanto pare siamo sul terreno dell’incerto. Chi è il padre? Quello che dà il nome, quello che dà lo sperma, quello che dorme con la mamma e firma le pagelle scolastiche? E quando si diventa padri? All’esito di un test di gravidanza, quando lei ti dice “è tuo figlio”? Quando vedi la prima immagine dell’embrione con l’ecografia? Quando si va all’anagrafe per dichiarare la nascita e il nome di un figlio? Padre giuridico, biologico, educatore, adottivo, padre spirituale. Le molte declinazioni della paternità portano a quella che la psicanalista francese Geneviève Delaisi de Parseval ha definito paternità “negoziata”.
Il report Fathers Direct costringe comunque a chiedersi in che cosa consista la paternità. A quanto pare siamo sul terreno dell’incerto. Chi è il padre? Quello che dà il nome, quello che dà lo sperma, quello che dorme con la mamma e firma le pagelle scolastiche? E quando si diventa padri? All’esito di un test di gravidanza, quando lei ti dice “è tuo figlio”? Quando vedi la prima immagine dell’embrione con l’ecografia? Quando si va all’anagrafe per dichiarare la nascita e il nome di un figlio? Padre giuridico, biologico, educatore, adottivo, padre spirituale. Le molte declinazioni della paternità portano a quella che la psicanalista francese Geneviève Delaisi de Parseval ha definito paternità “negoziata”.
Posto che il discorso non può essere dissociato da quello sui ruoli sessuali, e in particolare sul ruolo del sapiens maschio nelle diverse culture, proviamo a delimitare alcune tematiche o, meglio, “zone” di declinazione della paternità.
Zona parto
I padri, a volte, sono un po’ imbranati. E fanno danni. Conosco un signore che ha spezzato entrambe le braccia a sua figlia di due anni, tirandola a sé per abbracciarla. I padri, a volte, sono un po’ paurosi: a dire il vero, quasi nessuno si sente pronto per diventare padre; poi succede, ed è bellissimo. I padri, a volte, sono un po’ impressionabili. Lo svenimento in sala parto è un classico. Ma chi ha detto che occorra entrarci a tutti costi, con la cuffia in testa e la videocamera in mano?Archiviate le barzellette che hanno sempre ritratto i padri fuori, sul corridoio, a fumare innumerevoli sigarette, a un certo punto sembrò politicamente corretto spingere i padri in sala parto. Un dogma di partecipazione, vagamente femminista, che non sempre si è rivelato una buona idea. Soprattutto quando la partoriente, o il futuro padre, non ne avevano la minima voglia. Psicologi e ginecologi, di genere maschile e femminile, oggi ammettono qualche forzatura in questo senso. Salvo il fatto che per un uomo equilibrato (qualunque significato possa avere questo aggettivo) si tratta di un’esperienza meravigliosa. I problemi seri iniziano dopo. La guida del giovane papà di Pierre Antilogus e Jean-Louis Festjens ( EDT, 1991) non  lo nasconde. Il repentino passaggio dalla categoria protetta di figlio a quella esposta di genitore può causare crisi postnatali anche nei padri. Non sempre si è preparati a reggere la botta della paternità. “Bisognerebbe essere un robot d’acciaio, oppure un cretino integrale, per attraversare questa crisi particolarissima senza avvertire nessun timore, senza provare il minimo turbamento esistenziale”, scrivono gli autori della guida. Le reazioni variano. Si va dalle cosiddette follie paterne (evasione, eccessi, sindrome di Peter Pan), alla depressione. Partorire, in ogni caso, è l’unica cosa che un padre non può fare. Anche se sono clinicamente noti, nei maschi, sintomi correlati alla gravidanza, come ingrossamenti del girovita e misteriose coliche epatiche. La verità è che sul piano rituale siamo scarsissimi: la paternità è pur sempre un passaggio, come celebrarlo?
lo nasconde. Il repentino passaggio dalla categoria protetta di figlio a quella esposta di genitore può causare crisi postnatali anche nei padri. Non sempre si è preparati a reggere la botta della paternità. “Bisognerebbe essere un robot d’acciaio, oppure un cretino integrale, per attraversare questa crisi particolarissima senza avvertire nessun timore, senza provare il minimo turbamento esistenziale”, scrivono gli autori della guida. Le reazioni variano. Si va dalle cosiddette follie paterne (evasione, eccessi, sindrome di Peter Pan), alla depressione. Partorire, in ogni caso, è l’unica cosa che un padre non può fare. Anche se sono clinicamente noti, nei maschi, sintomi correlati alla gravidanza, come ingrossamenti del girovita e misteriose coliche epatiche. La verità è che sul piano rituale siamo scarsissimi: la paternità è pur sempre un passaggio, come celebrarlo? 
Zona etnica
E allora, dalla sala parto, entriamo in zona etnica. Quello che per certa psicologia nostrana suona sinistramente come “delirio di gravidanza” in etnologia ha un nome più dignitoso, si chiama couvade (o covata, all’italiana). Nella letteratura scientifica anglosassone è nota come sympathetic pregnancy. “Nella provincia cinese di Cardandan”, scrive Marco Polo nel XIII secolo, “subito ch’una donna ha partorito si leva dal letto e il marito si mette a giacere in sua vece, e tiene il figliuolo appresso di sé, avendo la cura di quello per quaranta giorni, che non si parte mai”. In diverse culture (oggi si va dalla Cina all’Amazzonia, un tempo era usanza tra i Corsi, i Sardi e i Baschi) quando arriva il momento di partorire, gli uomini affermano la loro paternità attraverso una partecipazione rituale alla nascita, al fine di proteggere da influssi nefasti la madre e il neonato. In pratica, simulano la gestazione e le doglie. Presso gli Erukala, etnia dell’India meridionale, quando inizia il parto, ancora oggi il marito indossa gli abiti della moglie, si sdraia sul letto e si copre con un lenzuolo.
L’etnografia è ricchissima. Gli Inuit della Groenlandia e i Daiaki del Borneo credono che in fase parto il marito non debba lavorare con strumenti taglienti, né uccidere animali, poiché altrimenti danneggerebbe il nascituro. In area melanesiana, padre e figlio non sono legati da parentela: i figli sono generati da uno spirito inviato dagli antenati del clan della madre. L’uomo di riferimento, in questo sistema famigliare, è lo zio materno. Ciò non toglie che il marito non sia del tutto estraneo alla formazione del bambino: i rapporti sessuali durante la gravidanza servono a plasmare nell’utero le sembianze fisiche del nascituro. In Benin (antico Dahomey) la donna che paga il prezzo della sposa diventa un marito e perciò anche un “padre femmina” dei figli che verranno, in seguito a contatti con uomini da lei prescelti. Fra i Nuer del Sudan il ruolo di padre può essere svolto dal fantasma di un parente defunto della madre. Tra i patrilineari Soninké (Africa occidentale) il prezzo della sposa serve a comprare un diritto di proprietà sui nascituri: se la moglie non genera, il suocero deve rifondere. L’antropologa Margaret Mead ha studiato a lungo gli Arapesh della Nuova Guinea: gli uomini qui sono monogami, rifiutano la professione di guerriero e si occupano dei figli. Ma in Nicaragua e in diversi paesi dei Caraibi la dedizione e la fedeltà di un padre si misurano anzitutto nei confronti della propria madre. Poi verso la moglie e i figli.
Zona patria
La cosiddetta parentela agnatizia (tipica del diritto romano) si riferisce a tutti gli individui legati tra loro attraverso la linea maschile. Proprio perché il padre è incertus, gli uomini hanno sempre avuto un problema di discendenza. Protezione e potere sono connessi, come c’è un nesso tra il patriarcato e il patrimonio. Quando vi sia residenza patrilocale (la sposa va a stare da lui) e discendenza patrilineare, siamo in presenza di un complesso di maschilità ege monica, detto patrifocale. Il settanta per cento delle culture umane ha un modello patrilocale. Nella cultura mediterranea, è subito “padre padrone”. Non manifestandosi naturalmente come la maternità, la paternità deve fondare la sua legittimità su un atto di autorità. E facendo appello all’autorità è divenuta essa stessa icona di potere. Autorità e paternità, insomma, si fondano una sull’altra, all’interno di un ordine paradigmatico. Assente Ulisse, a Itaca va in scena un disordine spettacolare.Alle soglie della contemporaneità, la figura del padre inglese vittoriano rappresenta ancora l’ordine: famigliare, sociale e politico. Basterà un pizzico di magia per mandare tutto all’aria? Nel film “Mary Poppins” di Robert Stevenson (1964) assistiamo a una rivoluzione: George W. Banks, tetro e severo impiegato di banca, con prole e moglie femminista radical chic, inopinatamente si “libera”. Grazie all’intervento (forse più seducente di quanto venga esplicitato) della signorina Julie Andrews, nei panni dell’istitutrice Mary Poppins, l’uomo manderà a quel paese il capo e imparerà finalmente... a ridere. Un discreto campanello, a quattro anni dal Maggio francese, che - più o meno consapevole della lezione di Freud - darà la spallata definitiva alla tirannia politica del patriarcato. Perché il ‘68 fu anche ribellione contro i padri, castra(n)ti e omologa(n)ti, e illegittimi oppressori di Madre Terra.
monica, detto patrifocale. Il settanta per cento delle culture umane ha un modello patrilocale. Nella cultura mediterranea, è subito “padre padrone”. Non manifestandosi naturalmente come la maternità, la paternità deve fondare la sua legittimità su un atto di autorità. E facendo appello all’autorità è divenuta essa stessa icona di potere. Autorità e paternità, insomma, si fondano una sull’altra, all’interno di un ordine paradigmatico. Assente Ulisse, a Itaca va in scena un disordine spettacolare.Alle soglie della contemporaneità, la figura del padre inglese vittoriano rappresenta ancora l’ordine: famigliare, sociale e politico. Basterà un pizzico di magia per mandare tutto all’aria? Nel film “Mary Poppins” di Robert Stevenson (1964) assistiamo a una rivoluzione: George W. Banks, tetro e severo impiegato di banca, con prole e moglie femminista radical chic, inopinatamente si “libera”. Grazie all’intervento (forse più seducente di quanto venga esplicitato) della signorina Julie Andrews, nei panni dell’istitutrice Mary Poppins, l’uomo manderà a quel paese il capo e imparerà finalmente... a ridere. Un discreto campanello, a quattro anni dal Maggio francese, che - più o meno consapevole della lezione di Freud - darà la spallata definitiva alla tirannia politica del patriarcato. Perché il ‘68 fu anche ribellione contro i padri, castra(n)ti e omologa(n)ti, e illegittimi oppressori di Madre Terra.
Ma l’antropologo Franco La Cecla mette in guardia contro certi schematismi: “I padri o sono accusati per la loro assenza, o sono trattati come strane figure leggermente effeminate che fanno scelte singolari e controcorrente: come se essere padri fosse un nuovo tipo di hobby (...) La paternità è stata pensata, fino a pochissimo tempo fa, come il retroterra della storia dei poteri dominanti. Per questo si è ignorato che è esistita una paternità affettiva, che ci sono evidenze in tutti i tempi di un rapporto emozionale e di coinvolgimento dei padri con i loro figli (Modi bruschi, Bruno Mondadori, 2000).
Zona rosa
Il tramonto è rosa. E di un tramonto parla Sandro Bellassai, nel suo studio su La mascolinità contemporanea (Carocci, 2004): quello del virilismo. Il complesso “misogino e omofobico” che ha segnato il Novecento si sfalderebbe, dunque, per generare altre figure, altri comportamenti. La mutazione è innegabile. Persino nel management delle aziende valori maschili come l’assertività e la conquista cedono ormai il passo a valori tradizionalmente considerati femminili, come la relazionalità e le emozioni. La stessa pubblicità oggi ci mostra uomini e padri diversi: amorevoli, domestici, qualcuno direbbe matrizzati. Padri marsupiali che girano in città con il bebè sul ventre, o spingendo il passeggino con lo sguardo perso all’orizzonte (o verso una moto che sgomma). Alcuni sono proprio tristi. Altri sono compresi nel loro ruolo di padri finalmente presenti.
Tra i grandi trend del XXI secolo il sito web www.2100.org segnala il declino dei valori maschili, 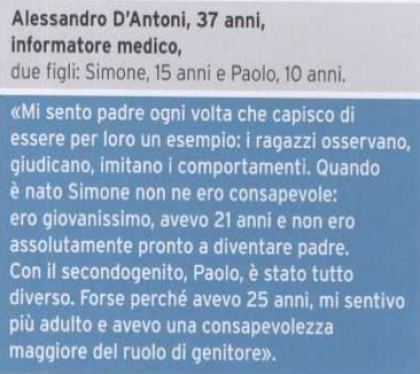 a vantaggio di una generale femminilizzazione del mondo. Più armonia, meno controllo, questo è il futuro. Mentre a stigmatizzare una “perdita di virilità” si ergono voci sorprendenti, come quella del vescovo di Pistoia nel luglio di quest’anno, e in generale della parte più conservatrice del clero. Progressi? Regressi? Certo è che a forza di lottare contro l’egemonia maschile, accusata di tutti i mali, la civiltà occidentale ha finito per contestare al padre anche il ruolo di educatore. Ma così facendo, oh mamme, non si rischia di buttare via il bambino (o il bambinone) con l’acqua sporca?
a vantaggio di una generale femminilizzazione del mondo. Più armonia, meno controllo, questo è il futuro. Mentre a stigmatizzare una “perdita di virilità” si ergono voci sorprendenti, come quella del vescovo di Pistoia nel luglio di quest’anno, e in generale della parte più conservatrice del clero. Progressi? Regressi? Certo è che a forza di lottare contro l’egemonia maschile, accusata di tutti i mali, la civiltà occidentale ha finito per contestare al padre anche il ruolo di educatore. Ma così facendo, oh mamme, non si rischia di buttare via il bambino (o il bambinone) con l’acqua sporca?
Zona Ypsilon
E’ la zona di rivalutazione del gene Y, appunto, quello maschile. Dove si riscoprono virilità e paternità positive. Il padre apporta un contributo specifico alla costruzione del linguaggio e dell’intelligenza dei figli. La sua tendenza a utilizzare un vocabolario più tecnico di quello della madre, e i suoi inviti a riformulare le domande (cosa? in che senso? quale di preciso?) ne fanno un interlocutore più esigente e impegnativo. Obbligano il bimbo a sforzarsi di farsi capire. Forse il padre gratifica meno, ma spinge a trovare soluzioni nuove e a progredire. Una scoperta, questa, che Jean Le Camus, professore emerito di Psicologia all’Università di Toulouse, non esita a definire sorprendente.
Perché si dice “un vero uomo”? Esistono forse i falsi uomini? Nelle diverse culture la maschilità non è mai data, com’è data la femminilità. Va invece costruita, attraverso una serie di prove, anche cruente. E così la paternità. Se il figlio non sta rannicchiato dentro lo spermatozoo, come appariva nel celebre disegno di Niklaas Hartsoeker del 1694, la paternità non va da sé, ma va per così dire lavorata. A maggior ragione nelle sue nuove manifestazioni. Padri separati e soli, padri gay, padri a singhiozzo (emigrati, businessmen, lavoratori stagionali) sono figure spesso condizionate da inediti assetti sociali. Per esempio, la precarietà d’impiego che oggi affligge molti padri, sia giovani sia di mezza età, li rende più fragili. Al punto da compromettere il loro rapporto con i figli. Con i quali stanno, sì, fisicamente più a lungo, ma – paradossalmente - proprio per questo vengono socialmente squalificati. E poi idealizziamo i padri pigmei!
Diventare padre non è obbligatorio, né necessario. Ma come ogni padre sa, è un’esperienza che trasforma in uomini... non dirò veri, ma interi. E attenzione ai ruoli. Un buon padre non è una specie di madre. Né una specie di fratello, perché quando il padre diventa un fratello, o un amico, il figlio si sente orfano. Forse un buon padre è quello che a un certo punto si fa da parte. E, senza per questo esaltare la propria discendenza, si lascia tranquillamente superare.